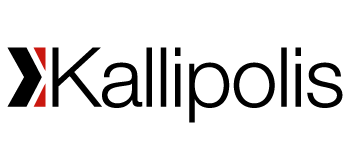News
News

Drop City intervista Andrea Forchino

Oggi Drop City intervista Andrea Alberto Forchino. Dopo la laurea magistrale in biologia all’Università degli Studi di Torino e il dottorato di ricerca presso l’Università dell’Insubria Forchino si sposta all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Qui lavora per 4 anni come assegnista di ricerca e professore a contratto occupandosi di acquacoltura, acquaponica e sostenibilità ambientale. Attualmente affianca al lavoro di docente quello di consulente per aziende e istituti di ricerca privati e pubblici nel campo dell’acquacoltura e della sostenibilità ambientale.
Come sei entrato in contatto con l’agricoltura fuori suolo?
Ho conseguito la laurea triennale in Scienze naturali, quella specialistica in Biologia e poi ho intrapreso l’attività di dottorato all’Università di Varese dove mi sono occupato di acquacoltura.
Dopo altre attività sono approdato a Venezia dove ho lavorato 4-5 anni presso l’Università Ca’ Foscari come assegnista di ricerca e professore a contratto. Qui mi sono occupato di acquacoltura, in particolare di acquaponica, sia di impiantistica, quindi progettazione e ottimizzazione di sistemi di acquaponica che di impatto ambientale. Assieme al gruppo di ricerca con cui ho collaborato, capitanato dal Prof. Roberto Pastres e dal Prof. Daniele Brigolin abbiamo vinto una serie di progetti specifici sull’acquaponica, come l’INTERREG Italia-Slovenia (Progetto BLUEGRASS) e, in seguito, ho portato avanti collaborazioni internazionali.
Finito il “periodo veneziano” sono tornato in Piemonte, dove vivo attualmente. Sono insegnante full time di matematica e scienze e continuo a fare il consulente sia per l’università Ca’ Foscari che per aziende private. Le consulenze che porto avanti riguardano sia l’acquacoltura che l’analisi del ciclo di vita.
Ho lavorato come consulente per diversi impianti di acquacoltura in tutt’Italia e al momento sto seguendo l’impianto di Novacoltura, azienda agricola di Renato Paolucci in provincia di Napoli.
Da un punto di vista di consulenze mi sono trovato a scrivere business plan e studi di fattibilità sugli impianti di acquaponica.
Quali sono i vantaggi di questo tipo di agricoltura?
Ho iniziato a studiare l’acquaponica nel momento in cui non era ancora molto conosciuta. L’acquaponica ha vissuto fasi alterne: all’inizio (anni ‘70) ha avuto un po’ di fortuna, poi è diventata un’attività alla moda in cui tutti credevano e in cui sono arrivati i primi finanziamenti; attualmente di impianti effettivamente produttivi ce ne sono pochi, a causa di una serie di problematiche.
Tra i vantaggi che si possono riscontrare vi è sicuramente la questione legata allo spazio, perché gli impianti di agricoltura fuori suolo permettono una coltivazione verticale, a basso impatto ambientale, soprattutto in termini di impronta idrica.
A differenza dell’idroponica, in cui entra preponderatamente la chimica, nell’acquaponica la chimica entra solo nella gestione dell’impianto, ma non sono previsti aggiustamenti chimici, quindi sostanze nutritive.
Se ci si trova in zone con scarsità idrica, investire in acquaponica può avere senso, perché permette di produrre contemporaneamente pesci in acqua dolce e piante in coltivazione con poco consumo idrico. In termini di sostenibilità ambientale-energetica, investire in questo tipo di attività dipende in primis da come è fatto l’impianto, che deve essere ottimizzato e pensato ad hoc rispetto alla coltivazione prevista. Dipende inoltre dal mix energetico che si utilizza, corrente elettrica o energia rinnovabile, e anche dalla localizzazione dell’impianto, dalla luce solare disponibile e dall’uso di illuminazione artificiale di cui necessita. Spesso mi viene chiesto se l’acquaponica è una pratica sostenibile o meno: in merito a ciò si può quindi dire che da un punto di vista energetico dipende da come viene impostato l’impianto, da un punto di vista economico invece sicuramente l’acquaponica da sola non riesce a sussistere, bisogna pertanto perseguire l’integrazione di diverse attività che possano coesistere con essa. Il consumo energetico può essere molto alto (led, riscaldamento) quindi diventa complicato rientrare nei costi di produzione. La prima domanda da porsi quando si vuole investire su un impianto del genere è chiedersi quale è lo scopo di quest’ultimo: se voglio standardizzare la produzione, quindi voglio produrre il massimo possibile e controllare tutto, vuol dire che avrò dei costi di investimento e mantenimento enormi.
La sostenibilità è, da questo punto di vista, una questione di aggiustamento dell’impianto, una “taylorizzazione” in base alla sua localizzazione, per sfruttare le risorse e le potenzialità che ho a disposizione.
Progettare bene l’impianto vuol dire abbattere i costi di gestione. Questi ultimi si riferiscono a una delle parti più complesse del sistema in quanto si mettono insieme competenze trasversali. Nel caso dell’acquaponica per esempio va prevista una figura esperta di produzione ittica da acquacoltura e una figura esperta nell’ambito vegetale. Molti pensano che fare agricoltura fuori suolo sia una pratica semplice e sostenibile, ma così non è. Se ho un impianto che funziona molto bene in una determinata posizione geografica, non vuol dire che funzioni allo stesso modo in un’altra. Devo necessariamente proporre delle modifiche in base alle differenze geografiche e alla potenzialità di quella zona (inclusa quella di mercato). Non esiste un impianto standard applicabile a qualsiasi contesto, perché creerebbe un sistema non ottimizzato. Ogni impianto è unico, in base a cosa si coltiva, a quali pesci si intende introdurre, etc.
Da un punto di vista legislativo, inoltre, è un dramma, perché la parte burocratica non ha necessariamente esperienza in materia: spesso vengono quindi imposti vincoli e definizioni “calate dall’alto” difficilmente comprensibili e applicabili.
Rispetto all’esperienza napoletana di cui sopra, ciò che stiamo cercando di realizzare è un impianto che riesca ad autosostenersi con le proprie forze, senza ricorrere a finanziamenti.
Tra idroponica e acquaponica quali sono i principali vantaggi/svantaggi?
Da un punto di vista di impatto ambientale tra le due tecniche è preferibile l’acquaponica. Per quanto riguarda le problematicità, in entrambe le tecniche di agricoltura fuorisuolo emergono le stesse, perché entrambe hanno sistemi che devono essere condizionati da un punto di vista di temperature, luce etc.
Nell’idroponica si ha il vantaggio di produrre molto in maniera standardizzata perché si aggiungono soluzioni di nutrienti (che hanno per contro un impatto ambientale). Nell’acquaponica invece, seppur con un minor impatto idrico, è il mangime dei pesci a produrre a sua volta un impatto ambientale. Qui però il rapporto di produzione è spostato sui vegetali: si ha meno pesce rispetto ai vegetali che si producono. L’idea che la componente vegetale e animale coesistano è molto interessante sia da un punto di vista commerciale, di business che di cultura. Si incarna infatti il concetto di economia circolare: si hanno due prodotti in cui l’output di uno diventa l’input dell’altro.
Personalmente tra i due prodotti prediligo l’acquaponica perché vi è meno chimica.
Pensi che sia vantaggioso inserire impianti di agricoltura fuori suolo in contesti urbani dismessi?
Secondo me sì, uno tra i vantaggi di inserire queste colture in contesti cittadini è quello di ridurre lo spazio/tempo tra produzione e vendita, promuovere la filiera corta e quindi incentivare il km0. Resta importante ragionare sul dove localizzare questi impianti e sulla dimensione che essi devono avere: è bene ricordare in merito a questo che la dimensione non è direttamente proporzionale al guadagno.
Quando si decide di investire in questo settore bisogna chiedersi se è meglio avere un grande impianto tecnologico o più impianti piccoli che riesco a gestire più facilmente. La soluzione, per me, sta nel mezzo: spesso conviene utilizzare spazi più piccoli. Infine bisogna stare attenti alle competenze necessarie per gestire tali impianti.
Rispetto alle tue esperienze, raccontaci quella più riuscita e quella più critica e quali sono state le cause di successo/insuccesso.
Ci sono state diverse esperienze interessanti, tra le quali l’impianto a Napoli e quello in Belgio.
Due esempi molto diversi tra loro: quello in Belgio completamente indoor, con enormi consumi energetici e tasso di produzione molto alto; a Napoli invece è stato creato un impianto decisamente più low tech da un punto di vista tecnologico.
Nell’impianto di Napoli, con il tempo, le varie carenze derivate dal fatto che fosse un impianto low tech, le abbiamo sistemate inserendo quelle componenti di tecnologia essenziali all’interno dell’impianto. Sin da subito l’approccio è stato quello di avere un occhio di riguardo ai consumi e al portafoglio, partendo dall’essenziale e aggiungendo man mano il necessario, con il fine ultimo di produrre.
In Belgio invece è stato completamente diverso: l’impianto è stato finanziato, produce molto ma è fuori mercato da un punto di vista di costi di produzione e quindi non è replicabile, a differenza del modello di Napoli.
Personalmente penso che, anche qui, sia opportuna la giusta via di mezzo: se l’intento è quello di fare un impianto produttivo, le soluzioni troppo low tech non funzionano. D’altro canto anche il troppo high tech, a meno che non si riescano ad ammortizzare i costi di gestione, non funziona perché troppo dispendioso. La soluzione possibile può essere quella di fare un sistema che sia gestibile con il minor impatto economico possibile e sfruttare tutto ciò che si ha a disposizione (acqua, sfruttamento solare). Inoltre, si può seguire una ciclicità ambientale di produzione.
A livello di amministrazione locale, c’è qualche strumento che sarebbe applicabile e potrebbe facilitare l’inserimento di questi impianti in un contesto urbano?
Non saprei cosa risponderti. Ho seguito quest’anno l’impianto napoletano perché dovevamo inserire i pesci, per i quali è stato richiesto da parte dell’ASL un piano sanitario. Quando ci siamo interfacciarti con l’ASL nessuno sapeva di cosa stessimo parlando. Questo episodio è stato il segnale che spesso il rischio è proprio quello che gli enti impongono dei paletti normativi troppo stringenti per realtà piccole senza alcun tipo di conoscenze in merito.
In merito al mancato sviluppo di questo settore, pensi ci sia più mancanza di divulgazione del sapere/conoscenza o disinteresse/incertezza in merito?
Dipende di chi stiamo parlando: generalmente mi aspetto che sia più interessato ad approcciarsi al tema dell’agricoltura fuori suolo un ragazzo di 30/40 anni che ha una coscienza ambientale consapevole, rispetto a un signore anziano generalmente più restio all’innovazione. Sicuramente i problemi principali sono: le competenze nella gestione e la disinformazione. In generale quando ci si approccia a questi tipi di sistemi bisogna avere ben chiaro il focus per cui si vuole investire in questo settore.